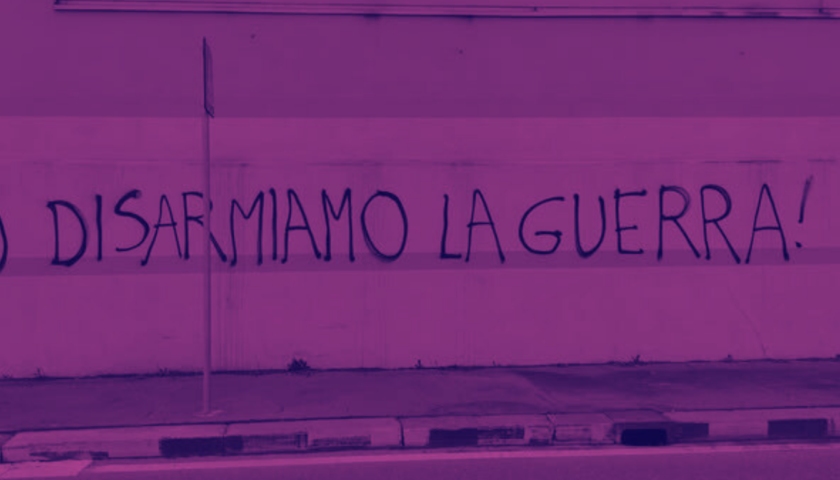EV: Antonio, quando e perché hai iniziato ad interessarti della Cina?
AC: Questo mio interesse è iniziato già durante gli anni sessanta – in pieno periodo maoista, sia nel senso dei rapporti di potere interni alla Repubblica, sia nel senso dell’interesse che questa esperienza suscitava in molti ambiti della sinistra rivoluzionaria. Io partivo da posizioni diverse dai seguaci del maoismo, ma proprio per questo cominciai ad interessarmi della effettiva realtà della Cina.
EV: La nostra chiacchierata verterà soprattutto sulla Cina odierna, ma potresti fare una veloce puntata sulla Cina del Presidente Mao?
AC: Non ci riesco in poche battute, dovremmo fare un’intervista a parte. Posso solo dire che, a mio avviso, la questione della Cina maoista è tuttora in larga parte da affrontare: gli strumenti analitici che si usavano all’epoca erano e sono inadatti, per cui un lavoro maggiormente analitico e definitivo è ancora da mettere in campo. In ogni caso, dopo il fallimento di quella tipologia di regime, la Cina è divenuta un paese pienamente integrato nel mercato mondiale capitalistico, dominato pienamente dalle sue leggi, dalla proprietà privata, dal profitto e dalle imprese multinazionali.
EV: Faccio l’avvocato del diavolo: ma in Cina c’è uno Stato dominato da un Partito che si definisce marxista che regola la politica economica complessiva…
AC: La presenza di uno stato interventista in economia non toglie e non mette rispetto all’essenza dei rapporti sociali capitalistici, in Cina come altrove. Marx voleva dedicare un ulteriore libro del Capitale al ruolo dello Stato nell’economia capitalistica, purtroppo la morte gli ha impedito di portare a termine il suo progetto. Altri però l’hanno fatto – ad esempio uno dei miei maestri, il marxista nordamericano Paul Sweezy, ha scritto cose notevoli in merito ed io continuo a concordare con lui, dedicando tra l’altro ben tre monografie al tema, oltre a vari articoli. (1)
EV: In generale, quali sono questi rapporti?
AC: La presenza dello Stato nell’economia capitalistica è la norma perenne e per nulla l’eccezione: lo sanno bene anche i capitalisti, i quali osannano il mercato, ma poi non si fanno remore a “mungere la vacca”…
EV: Insomma, “libero mercato” è il grido belluino di guerra degli imprenditori privati a caccia di finanziamenti pubblici…
AC: Carina questa, non la sapevo. Comunque diceva recentemente un economista della scuola di Chicago, Zingales, che nel mercato capitalistico l’attività più redditizia è quella del lobbying: Wall Street stanzia cinque miliardi per l’elezione di un presidente degli Stati Uniti e ne ricava, grazie alle sue politiche favorevoli, migliaia di miliardi. Lui, liberal/liberista vede la cosa negativamente e vorrebbe “ripristinare le regole del libero mercato” – ma questo non è materialmente possibile, per il semplice fatto che il “libero mercato” non è mai esistito, è solo una finzione ideologica che cerca di nascondere il continuo interventismo statale nell’economia capitalistica.
EV: Torniamo alla Cina.
AC: Giusto, ma non ce ne eravamo in realtà allontanati: per decenni i liberisti di tutto il mondo hanno presentato la Cina come una sorta di paradiso ritrovato, dove le regole del libero mercato, anche se applicate da un Partito dichiarantesi marxista, creavano un’economia vitale, con tassi di sviluppo oltre il 10%. In realtà, però, la Cina – e lo dico da molti anni – non è come dicono un grande paese sviluppato, ma semplicemente il più grande, come numero di abitanti, dei paesi sottosviluppati. Come ho scritto in un articolo di alcuni anni fa,(2) la Cina, insieme all’India, è un enorme tugurio sottosviluppato.
EV: Su cosa fondi la tua analisi?
AC: Innanzitutto, i livelli di produttività cinesi sono bassissimi: confrontata con i livelli medi dei paesi industrializzati dell’occidente, la Cina ha una produttività media intorno al 5%: detto altrimenti, per fare il prodotto di un solo lavoratore statunitense, tedesco o italiano ci vogliono venti lavoratori cinesi – il che significa che l’intera forza lavoro cinese è sottooccupata. In Cina, poi, il 35% della forza lavoro è impiegata in agricoltura: un dato comparabile con l’Inghilterra del censimento del 1811… la Cina, insomma, è due secoli dietro l’occidente di prima industrializzazione. Se poi contiamo che, in virtù della legge sul primo figlio, si stima che nelle campagne cinesi esistono circa duecento milioni d’individui “fantasmi” che lavorano in nero, la cifra potrebbe volare verso il 45%, dati comparabili con l’Inghilterra della seconda metà del XVIII secolo.
EV: Negli USA siamo sotto il 2% ed è un’agricoltura ultra industrializzata, pressoché il contrario della situazione dell’agricoltura cinese.
AC: Infatti. Per questo quando parlano del “colosso cinese” mi vien da ridere.
EV: Torna l’avvocato del diavolo: ma ha un PIL notevole o comunque nettamente superiore a quello dei paesi di antica industrializzazione…
AC: Certo, hanno il secondo PIL al mondo, ma sono almeno un miliardo e trecentocinquanta milioni di persone, per cui, se lo dividi pro capite, sono scarsi 8.000 $ per la Cina e 55.000 $ per gli USA. Questo è il conto che va fatto, altrimenti non si capisce nulla. Il trend, poi, non è affatto favorevole. Ho fatto delle elaborazioni: nel periodo tra il 2002 ed il 2012 il PIL pro capite cinese rispetto a quello USA passa dal 2,72% all’11,72% — perciò in dieci anni abbiamo una progressione di nove punti percentuali e, di questo passo, per raggiungere gli Stati Uniti ci vorrebbe un secolo… se la Cina mantenesse il tasso di sviluppo a due cifre che la ha caratterizzata negli anni che abbiamo considerato. Ma da alcuni anni il tasso è passato ad una sola cifra – attualmente il 6,5%. Parentesi: lo stesso discorso, anzi ancora peggio, vale per l’India che nel 2002 aveva un PIL pro capite pari all’1,32% di quello USA e nel 2012 ne aveva raggiunto solo il 2,9% — una progressione di circa un punto e mezzo in dieci anni e, per raggiungere gli USA, all’India occorrerebbero seicento anni. Inutile parlare poi della produttività del lavoro, della scienza, i brevetti per ogni centomila abitanti: distanze abissali. Passiamo poi all’industria automobilistica cinese di cui si dicono meraviglie. Anche lasciando da parte la qualità della produzione cinese che fa letteralmente schifo, nel 2013 in Cina circolavano settantacinque automobili ogni mille abitanti: da noi il rapporto è di cinquecento per mille – e si può fare lo stesso discorso per i pc, i telefonini…
EV: Come definiresti l’economia cinese, allora?
AC: Un caso tipico di sottosviluppo dinamico. Quando in un paese sottosviluppato apri una qualunque attività, il tasso di crescita s’innalza di molto in breve tempo: insomma, se ad un contadino che ha la ricchezza di una sola gallina gliene regalano un’altra, lo statistico dirà che la sua ricchezza nel volgere di un giorno è aumentata del 100%, ma lui resta sostanzialmente povero più o meno come prima. Stesso discorso per i “leoni africani”: se mi vantano la crescita del 14% del Ghana, ad esempio, ci si dimentica che si tratta di una crescita che parte da zero.
EV: Insomma, se in un paese del genere apri una qualunque attività, la crescita è immediata ma non significa nulla…
AC: … infatti, i problemi vengono dopo, quando devi crescere ulteriormente. Inizialmente è facile aumentare il reddito pro capite, poi, raggiunto un certo livello, vengono a galla tutte le difficoltà.
EV: Questo è quello che è successo un po’ di anni fa a quelle che erano definite le “tigri asiatiche”.
AC: Esatto. L’unica eccezione nell’area è il Giappone che ha iniziato la sua crescita centocinquanta anni fa, chiudendosi dietro barriere protezionistiche micidiali, sviluppando un’industria pesante e militare di tutto rispetto e solo dopo si è cimentato a livello mondiale. La situazione di paesi come Cina ed India è profondamente diversa: per muoversi sul mercato mondiale hanno brutalmente controllato i salari. La loro competitività non è di tipo tedesco o nipponico ad elevata tecnologia e qualità, ma è basata sui bassi prezzi dovuti ai salari da fame.
EV: Tornando alla Cina, si parla di zone molto vaste dove sussisterebbero situazioni di vera e propria schiavitù…
AC: Assolutamente, questo è indubbio: varie multinazionali sono finite sotto accusa per questo, ma il dato fondamentale è l’influenza dei consumi sul PIL cinese. All’inizio del “miracolo” cinese i consumi coprivano circa il 45% del PIL, il che era pochissimo: in quegli stessi anni negli USA eravamo al 70%, ma le scelte fatte di contenimento salariale hanno portato i consumi cinesi ad una quota del 34%. In pratica, per fare i consumi di un italiano ci vogliono occhio e croce una decina di cinesi.
EV: In pratica, un’economia che puntava pressoché esclusivamente all’esportazione.
AC: Infatti: finché il mercato ha tirato, la cosa ha funzionato; ma ora il mercato mondiale è in fase di stanca, distrutto anch’esso dai bassi salari e dalla disoccupazione e sottooccupazione reale, che è enormemente più elevata dei dati ufficiali. Questo dato è confermato da vari premi Nobel per l’economia ed anche da ministri del tesoro USA, che sono giunti a parlare di cifre quattro volte superiori alle statistiche ufficiali. Di qui la strozzatura dei consumi: si è andato avanti con l’indebitamento a favore della grandi aziende, ma questo un po’ dappertutto, anche in Cina, ha raggiunto livelli tali da non potere più andare avanti. È in una situazione di stagnazione continua da molti anni.
EV: Quindi non è un caso che la notizia di sei milioni di licenziamenti annunciati (3) siano tutti nel settore delle ultime aziende di proprietà statale.
AC: Certo: negli anni della crisi, dal 2008 ad oggi, quando lo sviluppo è passato da ritmi a due cifre a ritmi monocifra, queste aziende che non riuscivano più a vendere sul mercato mondiale ed anche in quello interno, sono state sovvenzionate, nella speranza si trattasse di una situazione contingente, con enormi investimenti che hanno creato sovracapacità produttiva; ma questo non è accaduto solo in Cina, né nei soli paesi poveri
(4). Tornando a noi, dai dati ufficiali del ministero dell’economia cinese, sappiamo che l’industria del cemento lavora al 73% delle capacità produttive, quella dell’alluminio al 76%, quella dell’acciaio al 71%, nella cantieristica, su trecento aziende, un centinaio ha commesse ed il resto vive di sovvenzioni statali.
EV: Sovvenzioni per i padroni del vapore e solo in minima parte per il mantenimento dei livelli occupazionali, che subiscono un’emorragia continua.
AC: Ovvio, non c’è neanche da dirlo.
EV: Come potrebbe uscire la Cina da questa situazione, restando all’interno dell’orizzonte capitalistico?
AV: Una prima ipotesi potrebbe essere quella, dato che il mercato mondiale non tira, di aumentare i consumi interni: ma cambiare un modello di sviluppo basato sulle esportazioni di prodotti a basso costo con uno basato sui consumi interni non è semplicissimo e tanto meno rapido. Chiede l’anima candida: ma se gli USA hanno questo genere di modello, perché non potrebbero seguirli su questa strada i cinesi? Il fatto è che i salari e quindi i consumi non salgono solo perché un economista dice che bisogna cambiare modello di sviluppo, ma occorrono alcune condizioni che il governo cinese non ha alcuna intenzione di introdurre: in primo luogo le libertà sindacali, perché nessuno ti regala niente in una società capitalistica. Sempre restando all’interno dell’orizzonte capitalistico, i salari per crescere hanno bisogno di un aumento della produttività altrimenti l’impresa va in passivo – ma, come dicevamo, le industrie cinesi hanno una produttività bassissima. Occorrerebbe allora fare forti investimenti in tecnologia, ma questo significherebbe produrre di più con meno addetti e questo aumenterebbe la disoccupazione, contraendo ancora di più i consumi: se i cinesi raggiungessero i livelli italiani di produttività, basta fare un po’ di semplici calcoli, ci sarebbero circa settecento milioni di esuberi… Terzo fattore: occorrerebbe un mercato del lavoro favorevole al lavoratore, un mercato insomma dove due imprenditori inseguono lo stesso lavoratore per assumerlo, ma oggi la situazione viaggia nella direzione contraria, specie in Cina dove esiste una sottooccupazione enorme, specie nel settore agricolo, dove si guadagna mediamente meno della metà dei salari, comunque da fame, del settore industriale.
EV: Quindi la situazione, restando nell’orizzonte capitalistico, è bloccata, non se ne esce…
AC: È talmente drammatica la situazione che i cinesi stanno scappando, ma non quelli delle classi lavoratrici, bensì di quelle dominanti, perché il sistema economico non funziona più e si temono esplosioni di rabbia sociale di enorme portata.
EV: Tra l’altro stiamo parlando di un paese dove, secondo le dichiarazioni ufficiali dello stesso governo, abbiamo un numero impressionante di rivolte…
AC: Stavo per dirlo. Nel 2005 lo stesso Presidente della Repubblica cinese parlò davanti al parlamento di novantamila rivolte annue contro le novemilatrecento di dodici anni prima; in tempi più recenti la Banca Popolare di Cina e varie Università hanno confermato numeri simili. È come se in Italia ci fossero quattromilacinquecento rivolte all’anno… allora diremmo che l’Italia è in una fase preinsurrezionale! L’esercito cinese è composto da poco più di due milioni di unità, la polizia vede cifre simili, mentre i cinesi sono almeno un miliardo e trecentocinquanta milioni, ma probabilmente sono ancora di più. Il territorio per di più è enorme e se le rivolte cominciano a coordinarsi esplode tutto: per questo le classi dominanti cercano la fuga all’estero. I paesi dove la classe dominante cinese si dirige maggiormente in questa vera e propria fuga (5) sono Stati Uniti e Canada: ovviamente portano con sé tutti i loro averi, che non sono propriamente pochi. Nel 2015, sono dati dunque recentissimi, la Banca Popolare di Cina ha denunciato quella che lei stessa ritiene un’emorragia enorme di capitali: (6) ben cinquecento miliardi di dollari avrebbero preso la via dell’estero, nonostante le rigide norme bancarie cinesi. Nei primi due mesi di quest’anno, poi, voci accreditate parlano addirittura di cento miliardi di dollari al mese. Un Centro Studi, il Deal-logic, per fare un confronto, ha calcolato che in Cina in questi stessi due mesi ci sarebbero stati investimenti all’estero in campo industriale per ottantuno miliardi di dollari. (7)
EV: Ora faccio l’anima bella: ma i capitalisti cinesi non potrebbero investire i loro capitali che so, nel campo agricolo, così tanto arretrato che un arricchimento tecnologico dovrebbe dare frutti forse maggiori che non spostandoli nelle banche occidentali?
AC: I capitalisti cinesi investono molto soprattutto nel debito pubblico statunitense, che viene da loro sostenuto al momento attuale per circa millecentocinquanta miliardi di dollari; questo perché, venendo alla tua domanda da anima bella, in realtà l’agricoltura cinese – dell’industria abbiamo già parlato – è talmente arretrata, le spese sarebbero così elevate, che per avere un ritorno degli investimenti, ammesso che ci sia, i tempi non sarebbero affatto rapidi ma biblici, nell’ordine forse dei decenni. Se invece investono nel debito pubblico occidentale e/o in partecipazioni azionarie hanno un ritorno immediato. Dunque la fuga è dovuta sia a motivazioni economiche – è finito il “miracolo” – sia a motivazioni socio-politiche – la paura di una rivolta. Le cose sono ovviamente interrelate.
EV: David Graeber, in Debito, sostiene che in realtà questo finanziamento cinese e degli altri paesi BRIC non significa per nulla una sorta di controllo di questi sull’economia occidentale, ma l’esatto contrario: si tratterebbe non di un prestito, ma della versione moderna di un tributo che il paese dominante imperiale impone ai paesi satelliti.
AC: Verissimo. La caratteristica del capitalismo è che sono i paesi poveri a finanziare i paesi ricchi, niente affatto il contrario! Ho sempre criticato la tesi di Lenin – notoriamente una ripresa di quelle di Hobson, teorico dell’imperialismo – che accettava l’idea che fossero i paesi ricchi imperialisti, magari non per bontà ma per il loro interesse, a finanziare i paesi poveri per dotarli di infrastrutture, ecc. Si tratta, in pratica, di una tesi apologetica del capitalismo, da me criticata aspramente anche di recente: (8) in realtà, sono i poveri che finanziano i ricchi, sempre, sia all’interno delle nazioni sia nei rapporti tra le nazioni. Questo si è visto anche durante la crisi petrolifera degli anni settanta, che è citata spesso come esempio di trasferimento di ricchezza dai paesi ricchi verso i paesi poveri: in realtà questi soldi andarono alle classi dominanti dei paesi arabi e ritornarono pressoché subito nei paesi ricchi, che furono inondati dai nuovi investimenti delle élites arabe e dai loro rinnovati consumi di prodotti occidentali – beni di lusso e, specialmente, armi per i loro eserciti e polizie. Varie ricerche, già nel passato, (9) hanno mostrato tra l’altro come questi soldi non uscivano nemmeno dai paesi ricchi, ma passavano semplicemente da un conto all’altro delle stesse banche! In quegli anni mi trovai a camminare per Francoforte per la cosiddetta “strada delle banche” e pensai tra me e me che in quel posto i soldi passavano dal piano di sopra a quello di sotto e viceversa… Insomma, il tutto rimane in un circolo controllato dall’interesse dei paesi ricchi, un circolo di cui ovviamente fanno parte anche le élites, per esempio, dei paesi arabi, i cui interessi sono quelli del capitalismo internazionale e non certo di quello locale dei loro paesi.
EV: Visto che siamo in argomento, tu spesso hai parlato degli assetti proprietari effettivi delle nazioni “emergenti”, per cui spesso, se si va a vedere, si scoprono aziende di proprietà occidentale. Io, in merito, faccio spesso l’esempio della Costa Crociere: il nome è italiano, l’equipaggio anche, tutti la credono un’azienda italiana, ecc., ma da quasi vent’anni è di proprietà di un armatore israeliano naturalizzato statunitense. (10)
AC: Inizierò dicendo che c’è chi sostiene, già dagli anni trenta del secolo scorso, che l’effettiva proprietà delle grandi aziende sarebbe dei manager che la gestiscono in base al loro “merito”, perché i proprietari “puri” non saprebbero nemmeno dove mettere le mani, se s’impegnassero direttamente nella gestione rischierebbero di far fallire la gallina dalle uova d’oro. È la tesi della “proprietà senza potere”, per cui, in quest’ottica, la faccenda degli assetti proprietari sarebbe poco importante. Una semplice indagine empirica mostra però che questa tesi è una sciocchezza, perché i manager sono sempre espressione degli assetti proprietari. I grandi proprietari mantengono talmente bene il controllo sulle loro aziende che, spesso, divengono vere e proprie dinastie, al punto che gli storici dell’economica parlano di un Rockfeller I, II, III, ecc., come se stessero parlando delle dinastie degli antichi faraoni… Anche di recente una ricerca pubblicata sull’Economist ha affermato che il 90% delle grandi imprese sono letteralmente dinastiche. Chiariamo questo: la proprietà domina, gli assetti proprietari effettivi, pertanto, sono importantissimi. Si tratta di una proprietà che, come dicono due economisti conservatori come Zingales e Rayan, si trasferisce per successioni testamentarie che, spesso, non hanno niente a che vedere con un preteso “merito”. Talvolta la proprietà, dunque il controllo effettivo dell’azienda, si trasmette anche in via matrimoniale. In Italia abbiamo avuto il caso Ferruzzi, dove il capostipite Serafino aveva un solo figlio maschio ed una caterva di figlie femmine che andarono in sposa a varie persone, che entrarono così per diritto ereditario nei vari consigli di amministrazione delle varie imprese Ferruzzi, che erano chiamati i consigli di amministrazione dei cognati! Dopo di che è arrivato Raoul Gardini, il cui unico titolo di “merito” era “marito di Idina Ferruzzi”, che ha portato alla distruzione l’intero impero.
EV: D’accordo, la proprietà non è per niente “senza potere”. Data questa premessa…
AC: … torniamo alla questione degli assetti proprietari effettivi delle aziende cinesi, anche se quanto dirò vale un po’ in generale per i paesi poveri. Certo, ci sono aziende davvero cinesi, ma un’indagine empirica ha mostrato, non molto tempo fa, che almeno il 60% delle esportazioni “made in China”, in realtà, erano fatte o da succursali di multinazionali – per la maggior parte statunitensi, europee, giapponesi. È noto come molte aziende italiane, per esempio, trasferiscano lì le loro attività, attratte dai bassi prezzi, dall’assenza di diritti sindacali, da una tassazione di favore. Oltre a ciò, va messo nel conto l’esistenza di joint ventures che formano aziende con capitale misto, tra cui quello cinese. Insomma, quelle che noi oggi chiamiamo aziende “cinesi”, assai spesso sono aziende occidentali, o giapponesi, o coreane, ecc. che di cinese hanno solo il nome e buona parte della manodopera. Ricordo una battuta de Il Padrino quando Marlon Brando risponde ad un tale che gli parla degli arabi e delle ricchezze petrolifere: “Picciotto, gli arabi siamo noi!” ed avrebbe potuto anche dire “i cinesi siamo noi”. Un altro aspetto che attrae le aziende dei paesi ricchi in nazioni povere come la Cina, oltre ai bassi salari, il controllo della forza lavoro, la tassazione ridotta, è lo scarso controllo sulla qualità e sicurezza del prodotto finale, nonché dell’impatto ambientale delle produzioni. Buona parte di queste produzioni di solito è venduta negli altri paesi sottosviluppati.
EV: Tra l’altro, si tratta di un processo generalizzato: qualche tempo fa era uscita la storia della Cina come “superpotenza scientifica”, ma un articolo apparso su Le Scienze
CITAZIONE DEL NUMERO ha mostrato come la grande maggioranza di queste ricerche siano fatte su commissione – in pratica un subappalto internazionale che utilizza le strutture cinesi come forza lavoro intellettuale a basso costo – delle Università nordamericane, europee, giapponesi, ecc. che ne detengono i brevetti proprietari. Un’ultima domanda: se la Cina è solo il più grande paese sottosviluppato, del tutto interno alla logica capitalistica anche se in una posizione subordinata, ecc., come spieghi il persistere, sia pure attenuato e ridotto, del suo mito in alcune aree della sinistra?
AC: Perché questi si basano, paradossalmente, sul fatto che gli apologeti occidentali del capitalismo vogliono rappresentare i paesi “emergenti” e la Cina in particolare come un paese in cui il capitalismo funziona e si sviluppa, a dimostrazione del fatto che questa forma sociale ha ancora possibilità davanti a sé, il che indirettamente fa apparire la scelta del governo cinese di entrare pienamente nella logica del capitalismo, come in qualche modo “vincente” e dai potenziali sviluppi futuri. Questa cosa si dice ancora oggi con un tasso di sviluppo dell’economia cinese al 6,5%, affermando che si tratta un tasso notevolmente superiore a quelli, per esempio, dei paesi europei: ma per le condizioni strutturali dell’economia cinese un simile tasso di sviluppo non è assolutamente nulla, è sintomo di recessione. Disse l’economista Dominick Salvatore in una intervista a RaiNews che un tasso di sviluppo cinese al 7% equivaleva ad un tasso di sviluppo dell’1% negli USA, dove, di fronte ad un dato del genere, si straccerebbero le vesti. Tra l’altro, aggiungo io, il calcolo di Salvatore è puramente quantitativo: se si dovesse fare un discorso qualitativo, tenendo conto dell’arretratezza complessiva dell’economia cinese di cui abbiamo parlato all’inizio, allora meglio non parlarne proprio. Il concetto di “recessione” presente nei nostri manuali di economia, che dice che per parlare di recessione occorre che il PIL cada per due trimestri consecutivi, non si può applicare ai paesi sottosviluppati, dove occorrono tassi di sviluppo a due cifre. Da questa situazione, non sapendo come uscirne, il governo cinese sbanda: da una parte dice “aumentiamo i consumi”, però poi svaluta lo Yuan (ad Agosto 2015 lo hanno svalutato tre volte nel giro di pochi giorni) che è una mossa che deprime i consumi: infatti, dopo la svalutazione dello Yuan sono comunque diminuite le importazioni, perché i prezzi dei beni sono cresciuti, ma non sono affatto cresciute le esportazioni, perché il mercato mondiale non tira ed anche a prezzi minori non si riuscirebbe a vendere e, di conseguenza, non si compra. D’altronde, non è che i governi dei paesi ricchi brillino per intelligenza e tanto meno per coerenza: i vari G7, G8, G20 finiscono tutti ogni volta con dei documenti sintetizzabili così: “vogliamo la botte piena, la moglie ubriaca e l’uva nella vigna”. Dicono, infatti: “dobbiamo aumentare l’occupazione, ma dobbiamo anche rendere competitiva l’economia, cioè produrre di più con meno addetti; dobbiamo aumentare i consumi, ma dobbiamo anche controllare i salari; dobbiamo aumentare gli investimenti, ma non dobbiamo aumentare il debito pubblico, anzi dobbiamo diminuirlo; dobbiamo aumentare i prezzi perché sono troppo poco remunerativi, ma, come detto prima, dobbiamo aumentare i consumi…” – da un certo punto di vista la lettura di questi documenti dove si auspica tutto ed il suo contrario sarebbe esilarante, se la situazione non fosse tragica.
a cura di Enrico Voccia
- CARLO, Antonio, Il Capitalismo Inpianificabile, Napoli, Liguori, 19792 (I edizione 1976); ID, La Società Industriale Decadente, Napoli, Liguori, 20013 (I edizione 1980); ID, Il Leviatano Morente, Napoli, Liguori, 20013 (I edizione 1981).
- CARLO, Antonio, “L’Economia Globale: un Titanic Che affonda”, in www.crisieconflitti.ti (2007).
- VOCCIA, Enrico, “Se Sei Milioni vi Sembran Pochi”, in Umanità Nova, n. 8, 2016, p. 2.
- Nel 2011, il Centro Studi della Confindustria ha valutato che, a causa del basso utilizzo degli impianti si è perso in quell’anno un valore pari al 2,6% del PIL dell’eurozona. Peraltro, anche negli USA negli ultimi decenni difficilmente si è superato un livello di utilizzo degli impianti dell’80%. Questo significa che ogni anno una quota degli investimenti è sprecata; ma di questo gli statistici non tengono conto nel calcolo del PIL
- http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-02-06/la-grande-fuga-cina-che-zoppica-111027.shtml?uuid=ACgzg5OC.
- SANTEVECCHI, Guido, “Cina compra-tutto…”, in Corriere della Sera, 21/02/2016, p. 29.
- idem
- CARLO, Antonio, “La Putrescenza del Capitalismo Contemporaneo e la Teoria del Crollo”, in www.sinistrainrete.info (2012), paragrafo IX.
- Vedi CARLO, Antonio, “Studi sulla Crisi della Società Industriale”, Napoli, Loffredo, 1984, pp. 23-30.
- http://elogiodelfannullone.blogspot.it/2012/01/costa-crociere-non-e-italiana-il.html .